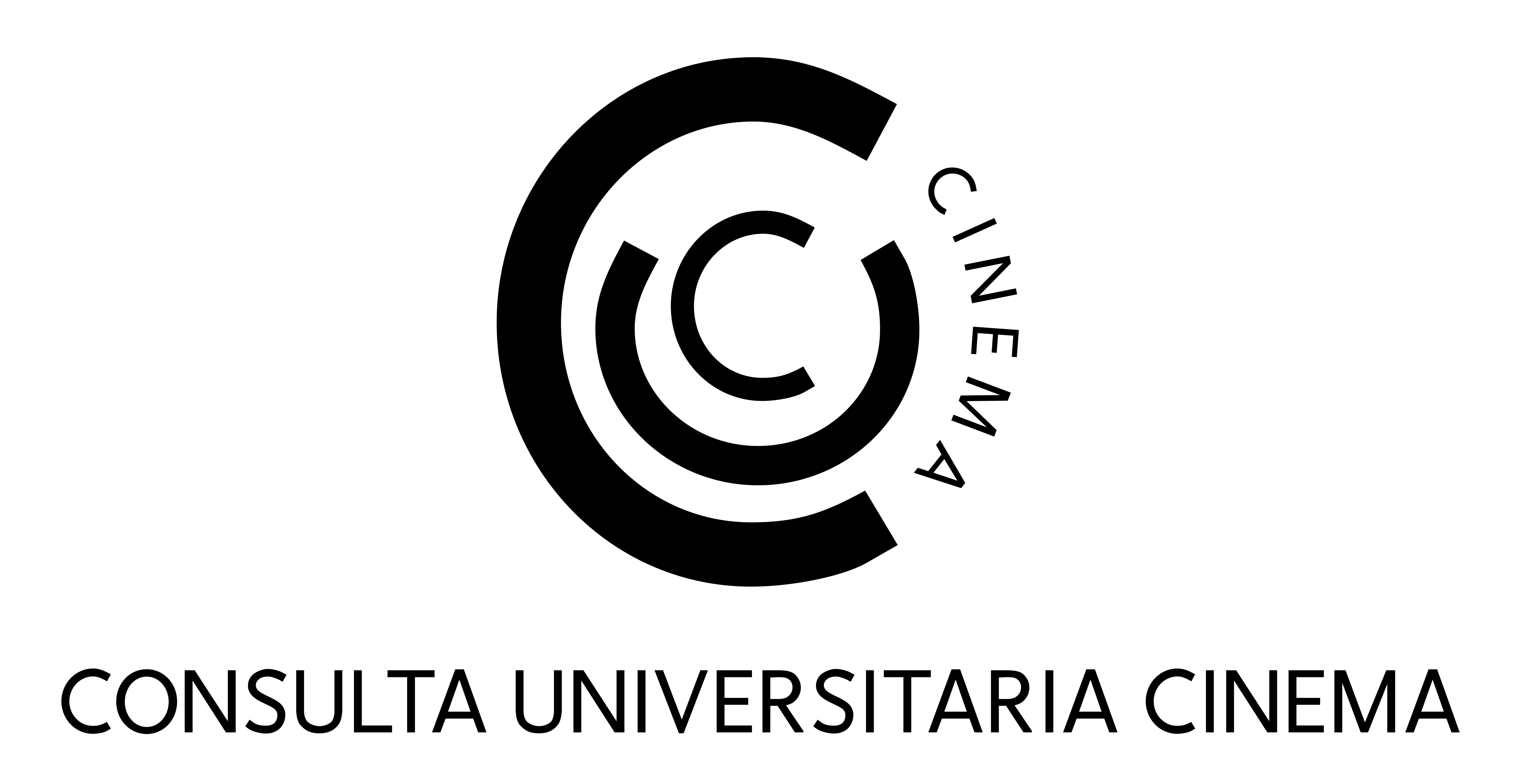Toy Story e oltre: la nascita di un mondo chiamato Pixar
Nel 1995 Toy Story di John Lasseter irrompe sugli schermi di tutto il mondo e cambia per sempre il volto del cinema d’animazione. Non è soltanto il primo lungometraggio interamente realizzato in computer grafica: è l’opera che dimostra come la tecnologia digitale possa farsi linguaggio, come gli algoritmi possano trasformarsi in emozioni e personaggi capaci di entrare nell’immaginario collettivo.
A cento anni dalla nascita ufficiale del cinema, un gruppo di creativi, informatici e imprenditori apre una fase nuova: la settima arte attraversa un passaggio che non riguarda soltanto l’innovazione tecnica, ma che investe le forme estetiche, i modi del racconto e la cultura di massa nel suo insieme.
Proprio a questa transizione epocale chi scrive ha deciso di dedicare un libro di prossima uscita per Carocci Editore (Pixar: Toy Story, Collana “Il cinema, i film”). Il testo non si limita a celebrare un classico, ma indaga la costruzione di un universo che da Toy Story in poi prende forma e si consolida, trasformando la Pixar in un fenomeno culturale transgenerazionale. Analizzando genesi, sviluppo e ricezione del franchise, il volume mostra come l’universo di Woody e Buzz non coincida soltanto con una saga fortunata, ma diventi un laboratorio capace di mettere insieme scienza e arte, industria e poetica, intrattenimento e riflessione. Il film che apre la saga diventa così il punto di partenza di un racconto più ampio, che prosegue fino ai giorni nostri e che fa della Pixar una delle realtà più emblematiche del panorama cinematografico contemporaneo.
È anche in ragione di questo anniversario (e in concomitanza con l’uscita del volume sopra menzionato) che la Consulta Universitaria del Cinema ha deciso di dedicare uno speciale alla Pixar: un percorso a più voci che, prendendo appunto spunto dai trent’anni di Toy Story, allarga l’attenzione all’intero “sistema Pixar” e alla sua capacità di ridefinire, film dopo film, l’immaginario globale.
Dove la tecnologia incontra il racconto
Guardare alla Pixar significa osservare un’esperienza complessa e stratificata. Le sue radici affondano in più tradizioni: da un lato l’eredità disneyana, con il sogno di dare vita al disegno e la tensione verso un’estetica cinematografica; dall’altro le sperimentazioni della computer grafica, sviluppate nei laboratori universitari e tecnologici degli Stati Uniti. A queste si sommano l’etica imprenditoriale della Silicon Valley e l’utopia californiana della tecnologia come strumento di libertà e creatività. La Pixar nasce precisamente dall’incontro di queste culture: quella della narrazione classica hollywoodiana, con la sua attenzione alle strutture e ai modelli archetipici, e quella della ricerca scientifica e tecnica, che vede nel calcolo la possibilità di generare nuove forme espressive. Non è un semplice compromesso tra due mondi: è un ibrido che costruisce un’identità originale, in cui la precisione algoritmica incontra la forza del racconto popolare.
Da questo innesto prende forma un’estetica peculiare. Pixar non ricerca mai un realismo fotografico, ma un verosimile emozionale: un “better than real” che rende credibile l’incredibile, trasformando giocattoli, automobili o emozioni in personaggi familiari. Non si tratta di imitare la realtà, bensì di produrre un universo parallelo che la rielabora e la intensifica. È un’estetica che vive della tensione tra naturalezza e artificio: ogni immagine porta impressa la complessità del calcolo digitale, ma la restituisce in una forma che appare al tempo stesso immediata, limpida ed emozionalmente complessa. È qui che si realizza la specificità dello studio: non la rincorsa all’iperrealismo, ma la costruzione di mondi riconoscibili e insieme trasfigurati, capaci di suscitare identificazione ed empatia.
Un tratto distintivo della poetica Pixar è la propensione ad animare l’inanimato. Fin dal corto Luxo Jr. (John Lasseter, 1986), la lampada che prende vita diventa emblema di un progetto che dà voce agli oggetti, alle cose, agli elementi della realtà materiale. In Toy Story sono i giocattoli a rivelare desideri e fragilità; in Cars (John Lasseter, 2006) lo fanno automobili antropomorfe; in Inside Out (Pete Docter, 2015) le emozioni si fanno personaggi; in Elemental (Peter Sohn, 2023) persino acqua e fuoco trovano forma e identità. Questa poetica non è soltanto un esercizio tecnico: riflette una concezione antropologica che allarga i confini dell’umano e invita a riconoscere un principio vitale anche in ciò che tradizionalmente viene considerato inerte. In questo modo, i film Pixar non raccontano soltanto storie, ma elaborano una nuova mitologia del presente in cui la differenza tra vivo e inorganico si sfuma per dar spazio a una comunità più vasta.
Dal laboratorio creativo al mito globale
Se la dimensione scientifica e quella poetica si intrecciano costantemente, anche la dimensione industriale e commerciale assume un ruolo decisivo. Pixar non produce soltanto film: costruisce universi narrativi che si proiettano oltre lo schermo. Ogni uscita diventa il centro di un ecosistema che si estende nei parchi tematici, nei videogiochi, nelle serie e nel merchandising, generando un brand globale riconoscibile e coeso. Ma questa proliferazione non comporta una perdita di coerenza narrativa. La forza della Pixar è quella di mantenere un’identità autoriale capace di sopravvivere anche alla serializzazione, garantendo che ogni derivazione sia coerente con i valori originari: emozione, crescita, relazione con l’altro.
In questo percorso i cortometraggi svolgono un ruolo importante, pur senza occupare la scena principale. Essi rappresentano un terreno di sperimentazione tecnica e narrativa, una palestra in cui si sviluppano idee, stili e soluzioni che spesso confluiscono poi nei lungometraggi.
Il rapporto con la Disney, inizialmente segnato da tensioni e rivalità, culmina nella fusione del 2006. Da quel momento Pixar acquisisce la forza industriale di un colosso globale, ma conserva un’identità propria, riconoscibile, fondata sull’idea che la tecnologia abbia senso solo se finalizzata alla narrazione e all’empatia. È questo equilibrio tra industria e poetica, tra macchina produttiva e invenzione artistica, a rendere lo studio un caso unico nella storia del cinema contemporaneo.
Non sorprende allora che la Pixar sia diventata un riferimento imprescindibile per comprendere le trasformazioni dell’immaginario globale. Ogni film intercetta i mutamenti della società americana e li trasfigura in storie universali: la crisi della famiglia nucleare, la pluralità delle identità, le sfide del multiculturalismo, il rapporto con la tecnologia. Al tempo stesso, la ricezione internazionale mostra come queste narrazioni siano capaci di parlare a pubblici diversi, travalicando i confini culturali e linguistici. Dalle comunità latine che si riconoscono in Coco (Adrian Molina, Lee Unkrich, 2017) ai giovani spettatori asiatici che vedono riflessa la propria esperienza in Turning Red (Domee Shi, 2022), la Pixar costruisce un dialogo transnazionale che la colloca al centro della cultura globale.
La sua capacità di incidere non si misura soltanto al botteghino, ma anche nel dibattito critico e accademico. I film Pixar vengono analizzati come testi che raccontano il presente, che riflettono sui processi di globalizzazione, che elaborano nuove forme di umanesimo. In questo senso, lo studio non è soltanto una fabbrica di intrattenimento, ma un dispositivo culturale che rielabora e ridistribuisce, in forme accessibili e coinvolgenti, le tensioni del nostro tempo.
30 anni in 5 puntate
Su queste basi prende forma lo speciale che la Consulta Universitaria del Cinema dedica alla Pixar in occasione dell’anniversario di Toy Story. Nelle prossime settimane usciranno “a puntate” i contributi di Marco Bellano, Federico Cadalanu, Alessandra Richetto, Chiara Roccatello e Cristina Formenti, membri del gruppo di lavoro CUC sul cinema d’animazione. I cinque saggi offriranno prospettive diverse e complementari: dall’intreccio originario tra scienza e animazione alla vocazione poetica che dà voce all’inanimato, dalle nuove rappresentazioni identitarie messe in scena negli ultimi film alla sfida tecnologica dell’intelligenza artificiale, fino alla riflessione sull’impatto ambientale di quest’ultima nell’ambito dell’animazione digitale.
Insieme, questi contributi andranno a delineare un ritratto composito e critico dell’universo Pixar, osservato nelle sue molteplici declinazioni lungo l’arco che dal vecchio conduce al nuovo millennio. Ne emergerà l’immagine di uno studio che, a trent’anni dall’esordio nel lungometraggio, non ha smesso di ridefinire i confini dell’animazione e di rinnovare l’immaginario collettivo globale, continuando a sorprenderci con la capacità di coniugare sperimentazione tecnologica, forza narrativa e profondità simbolica.